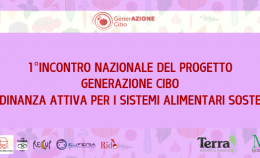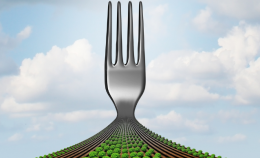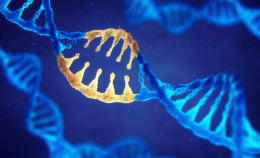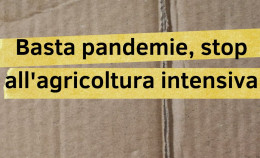Guerra in Ucraina: ultima scossa di un terremoto che sta colpendo le filiere globali del cibo
Pubblicato da Redazione
il 03/06/2022

Di Francesco Panié e Maria Panariello per Valigia Blu
L’ultima proposta è arrivata qualche giorno fa dal governo lituano: costruire una coalizione di “volenterosi” per ottenere una revoca del blocco navale imposto dalla Russia all’Ucraina, che in questo momento impedisce le esportazioni di grano dal paese est-europeo. La rotta del Mar Nero è infatti un’arteria cruciale per il flusso di commodities agricole - e del grano tenero in particolare - verso il continente africano. Diversi paesi nell’area dipendono dalle due nazioni in guerra per quote significative del loro import. Il Khubz, conosciuto anche come pane siriano, pita o pane libanese, è infatti uno degli alimenti base nella dieta in Medio Oriente e Nord Africa, ma gran parte della materia prima per produrlo arriva via nave da Russia e Ucraina. L’intero continente africano ha visto crescere drammaticamente il suo import di grano negli ultimi quarant’anni, minando lo sviluppo di sistemi alimentari locali.
La situazione è quindi potenzialmente esplosiva, con i due paesi in conflitto che hanno in mano il 31% dell’export globale di grano tenero e alcuni tra i principali partner in Libano, Egitto, Tunisia, senza contare alcuni stati dell’Africa sub-sahariana, che dipendono da Russia e Ucraina per quote di fornitura tra il 50 e il 100%. In molti di questi territori le persone spendono mediamente - nonostante i sussidi - fra il 35 e il 55% del loro reddito in cibo: il timore generalizzato è che l’aumento dei prezzi, acuito dalla scarsità dell’offerta causato dal conflitto possa innescare rapidamente una nuova bomba sociale.
Per questo, le domande che tutti si pongono al momento sono: come far uscire il grano bloccato nei depositi Ucraini? Come ripristinare le rotte del commercio mondiale dopo il rallentamento dovuto alla pandemia e l’interruzione causata dalla guerra? Come evitare una crisi alimentare in aree del pianeta che sono state teatro di rivolte non più di una decina di anni fa, proprio a seguito di un’impennata dei prezzi del pane che ha seguito la crisi del 2008?
Il cibo è diventato quindi un elemento strategico in questa fase del conflitto: un capitolo consistente della partita geopolitica in corso dipende proprio da come si assesteranno gli equilibri legati al commercio delle materie prime alimentari.
La soluzione intorno a cui si stanno concentrando gli sforzi è quella avanzata dal ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis: una scorta navale non gestita dalla Nato, ma dai singoli paesi interessati per “una missione umanitaria non militare e non paragonabile a una no-fly zone”. La cosiddetta coalizione farebbe da “cordone sanitario” per le navi cargo ucraine cariche di grano che al momento si sta ammassando nei centri di stoccaggio, garantendo l’attraversamento del Mar Nero e oltre le linee della flotta russa. La soluzione lituano-canadese è sostenuta dal governo britannico e poi dall'UE: ieri, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, il presidente del vertice Charles Michel l’ha definita “l’opzione migliore”, mentre si tentano anche altre alternative. La Russia ha fatto sapere, tuttavia, che la condizione per un accordo sullo sblocco dei porti è il ritiro di alcune sanzioni (richiesta ribadita in una telefonata avvenuta nel fine settimana con i leader francese e tedesco). Una missione del genere, in ogni caso, dovrebbe svolgersi sotto l'egida delle Nazioni Unite per essere effettivamente legale ai sensi del diritto internazionale. Ed è in questa direzione che l’UE ha intenzione di lavorare con più energie dopo il vertice conclusosi ieri. Nei prossimi giorni, infatti, Charles Michel incontrerà il Segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres.
La posta in gioco è alta e il tempo scorre: secondo Josef Schmidhuber, vicedirettore della Divisione Mercati e Commercio della FAO, quasi 25 milioni di tonnellate di cereali sono attualmente bloccati in Ucraina. Il tempo per esportarli è di tre mesi, prima che arrivi il prossimo raccolto. L’organizzazione sostiene, inoltre, che le truppe di Mosca stiano anche saccheggiando le strutture di stoccaggio per impadronirsi della preziosa materia prima e portarla in patria.
Binari morti
In attesa dell’apertura di corridoi alimentari, gli esportatori intanto guardano a Costanza, in Romania, come porto alternativo a Odessa. Treni, camion e chiatte vengono utilizzati per trasportare le merci nella strategica città portuale da piccoli porti sul Danubio come Reni e Izmail, nel sud-ovest dell'Ucraina.
Dal canto suo l’Unione europea sta provando a instradare il grano su una rotta che colleghi l’Ucraina al Mar Baltico tramite la Bielorussia. I checkpoint ferroviari ai confini con Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria sono le vie principali individuate dalla Commissione europea nel suo piano del 12 maggio, intitolato “Corsie di solidarietà”, mentre l’Europarlamento ha votato il 19 maggio per la sospensione di un anno dei dazi sulle importazioni da Kiev. Ma la capacità è molto inferiore rispetto ai porti marittimi. Le ferrovie ucraine inoltre non sono costruite per l'esportazione di simili quantità di cibo e le rotaie sono più larghe di quelle europee, e questo obbliga a scaricare e ricaricare ogni treno che attraversa il confine con la Polonia.
Secondo APK-Inform, un'agenzia di consulenza agroalimentare che copre specificamente i paesi dell’ex Unione sovietica, nei primi 22 giorni di maggio, l’Ucraina ha esportato appena 28 mila tonnellate di cereali, in particolare mais, mentre il problema rimane il grano. Per dare un’idea, l’Egitto da solo ha importato 651 mila tonnellate di grano tenero da Kiev nel 2021. A questo ritmo, servirebbero due anni, invece di tre mesi, per svuotare gli stoccaggi ucraini.
Prezzi alle stelle
La guerra però è solo l’ultimo elemento destabilizzante di una crisi del commercio internazionale innescata dalla pandemia. Da due anni ormai il mondo assiste a un aumento preoccupante dei prezzi alimentari. L’effetto rimbalzo causato da una ripresa della domanda dopo il crollo del Pil globale nel 2020 ha incontrato una siccità che sta colpendo le principali regioni produttrici del mondo, come Canada, India, Brasile, ma anche l’Europa mediterranea, come mostra il recente rapporto della Convenzione ONU sulla desertificazione (UNCCD). La riduzione dei raccolti è tra le cause di una impennata storica dei prezzi delle materie prime, ma con l’invasione russa dell'Ucraina il rialzo ha raggiunto livelli inediti.
Lo ha registrato anche l’indice dei prezzi alimentari della FAO (FFPI), che misura la variazione mensile dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari. L’FFPI è basato sulla media di altri 5 indici, che misurano i prezzi di altrettanti gruppi di prodotti scambiati sul mercato internazionale: cereali, oli vegetali, prodotti lattiero-caseari, carne e zucchero. Nel marzo scorso ha superato i 160 punti, il livello più alto da quando la FAO effettua le sue stime. Tutto questo ha originato un atteggiamento cautelativo da parte dei governi in molti paesi produttori di grano: l’India ad esempio, su cui tutti contavano per supplire alla carenza di offerta ucraina dovuta al blocco del Mar Nero, ha sospeso le esportazioni per sostenere il mercato interno.
Il segreto nei silos
A quella che viene ormai definita da più parti la “tempesta perfetta” del sistema alimentare, vanno aggiunte altre due determinanti: una è l’aumento dei prezzi dell’energia fossile, che impatta sul costo del trasporto navale e la produzione di fertilizzanti azotati e potassici, largamente utilizzati dall'agricoltura industriale. Secondo i Consorzi agrari d’Italia, nell'ultimo anno il prezzo di questi input agricoli è schizzato del 2-300%, passando in alcuni casi da 350 ad oltre 1000 euro a tonnellata. L’altra è il gioco dei distributori privati nei singoli paesi che, proprio come per la benzina, preferiscono trattenere il prodotto nei centri di stoccaggio anziché immetterlo sul mercato, facendone salire il prezzo così da aumentare il profitto.
Nonostante tutte le avversità menzionate in precedenza, infatti, il grano nel mondo non mancherebbe. Gli stoccaggi di cereali non sono calati drammaticamente e, da un secolo a questa parte, la produzione a livello globale supera la quantità consumata. Il collo di bottiglia è nella distribuzione. Quattro aziende nel mondo controllano il 70-90% del commercio internazionale di cereali: Archer-Daniels Midland, Bunge, Cargill e Dreyfus, conosciute con l’acronimo ABCD. Queste aziende non sono obbligate a rivelare le informazioni che hanno sui mercati globali, comprese le loro scorte di cereali. E con l'aumento della speculazione finanziaria sulle materie prime hanno un chiaro incentivo a trattenere le scorte fino a quando i prezzi non raggiungono il picco.
Chi scommette sulla fame?
Proprio la speculazione - sebbene se ne parli ancora poco - con la guerra ha raggiunto nuovi record sui mercati finanziari, un fatto che secondo diversi osservatori avrebbe gonfiato ulteriormente il prezzo dei prodotti. Un'indagine appena pubblicata da Lighthouse Reports rileva come l'eccessiva speculazione da parte di società di investimento e fondi finanziari nei mercati delle materie prime stia contribuendo alla volatilità, garantendo profitti stellari a player che con le loro operazioni starebbero riducendo l’accesso al cibo per milioni di persone. In pratica, nel mercato dei contratti a termine sui cereali (futures) si è verificato un massiccio ingresso di operatori speculativi come fondi di investimento, società finanziarie e operatori commerciali che non hanno alcun interesse nel commercio del cibo. Questi operatori acquistano contratti a termine sul mercato finanziario con l’idea di rivenderli a un prezzo maggiorato, scommettendo sulla crescita delle quotazioni. Quando il volume di questi scambi cresce vorticosamente, superando quello del “fondamentale” sottostante (cioè le tonnellate di grano materialmente scambiate), le quotazioni dei futures influenzano il cosiddetto prezzo spot, che dovrebbe essere dettato dalle dinamiche domanda-offerta. Con ricadute potenzialmente devastanti: le stime della Banca Mondiale avvertono infatti che per ogni aumento di un punto percentuale dei prezzi alimentari, 10 milioni di persone nel mondo oltrepassano la soglia della povertà estrema. Per dare una prospettiva della situazione, quando l’indice FAO a marzo ha raggiunto il record storico, segnava un +34% rispetto all’anno prima. Un picco ben lungi dall'essersi attenuato.
L’approvazione di normative su entrambe le sponde dell’Atlantico che avrebbero dovuto evitare nuove bolle come quella del 2008 (dove la speculazione finanziaria aveva raggiunto livelli simili agli attuali) non ha dato risultati. I gruppi di pressione del settore hanno bloccato o fortemente indebolito le norme volte a limitare la possibilità per gli attori speculativi di prendere d’assalto il mercato finanziario delle commodities agricole. Con il risultato che oggi la situazione è perfino più grave.
Soluzioni controverse alla sovranità alimentare
Questi moti tellurici che scuotono il mercato del cibo hanno riportato in auge termini come “sovranità alimentare”, un concetto coniato dalla Via Campesina nel 1996 per definire il diritto a un cibo sano e culturalmente appropriato, prodotto con metodi ecologici e sostenibili, ma soprattutto coltivato e scambiato a livello locale o regionale. Un manifesto per la de-globalizzazione dei sistemi alimentari, per evitare il loro utilizzo come clava geopolitica o strumento di speculazione finanziaria.
In questi mesi, infatti, sono aumentate le voci degli esperti e della società civile che chiedono di mettere in discussione il paradigma neoliberale, fare tesoro della crisi in corso e impostare un’epoca nuova in cui ridurre la dipendenza dalle filiere internazionali, sostenere i paesi del Sud globale senza più chiedere in cambio aggiustamenti strutturali e liberalizzazioni del mercato, ridurre la produzione e il consumo di carne e spostare i sussidi agricoli dalle colture industriali alle produzioni di piccola scala, orientate al mercato interno. In questo senso andava una lettera aperta inviata al governo italiano il 16 marzo scorso e firmata da 17 associazioni, tra cui la nostra.
Ad oggi però, queste richieste non hanno trovato ascolto. Le soluzioni individuate dalle istituzioni, infatti, vanno in un’altra direzione e seguono le richieste avanzate dai grandi gruppi di interesse del settore agricolo e agroalimentare. Negli Stati Uniti, sette organizzazioni di lobby stanno premendo sul Segretario all'Agricoltura, Tom Vilsack, per ottenere il consenso a coltivare a mais e grano quattro milioni di ettari che oggi ricadono all'interno di aree protette. Lo scopo sarebbe sopperire alle carenze di materia prima che potrebbero venire dall'impossibilità degli agricoltori ucraini di vendere la loro.
In Europa una retorica molto simile è stata utilizzata dal Copa-Cogeca, l’organizzazione ombrello che riunisce le principali sigle dell’agricoltura e del commercio agroalimentare nei 27 paesi. Nel vecchio continente le lobby hanno invocato in maniera strumentale la sovranità alimentare, ventilando il rischio di una carestia per i consumatori europei qualora non si fossero sospese le regole che obbligano gli agricoltori a tenere a riposo il 4% dei loro appezzamenti. Questa pratica, che oltretutto è sussidiata attraverso un meccanismo chiamato greening e previsto dalla Politica agricola comune (PAC), è fondamentale per mantenere in campagna delle zone di tutela della biodiversità, il cui collasso (principalmente causato dall’agricoltura industriale) è uno dei più grandi problemi globali, forse superiore al cambiamento climatico.
Che non ci sia un problema di carestia in Europa è dimostrato dal fatto che l’UE è autosufficiente dal punto di vista della produzione di cereali per il consumo umano, anzi è un esportatore netto. La guerra in Ucraina sta invece causando un problema alle filiere zootecniche, dipendenti da foraggere coltivate all'estero. In poche parole, manca il mais per alimentare gli animali: le imprese agitano quindi lo spettro della crisi alimentare per aumentare la produzione domestica a spese delle aree naturali, mentre le organizzazioni della società civile, tra cui Terra!, chiedono politiche strutturali di riduzione della domanda, superando il modello degli allevamenti intensivi.
Il 23 marzo scorso la Commissione europea ha dato ascolto al settore privato con una comunicazione del Commissario all’Agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski. Bruxelles permetterà per tutto l'anno di “derogare ad alcuni obblighi di greening”. In particolare, sarà consentita “la produzione di colture per l'alimentazione umana e animale su terreni incolti che fanno parte di aree di interesse ecologico nel 2022, mantenendo l'intero livello del pagamento”. In sostanza, si potranno spianare siepi, arbusti, boschetti o prati, coltivarli a foraggio e venderne il prodotto, ricevendo anche un sussidio per il servizio ecologico mai offerto. Il tutto, denunciano le associazioni ecologiste, senza che l’aumento della produzione su questi terreni possa sopperire alle milioni di tonnellate ferme nei depositi ucraini.
Ottenute le deroghe però, ora le lobby cercano di allargare la breccia e indebolire le strategie Biodiversità e Farm to Fork, legate al Green Deal europeo con orizzonte 2030, che contengono obiettivi di riduzione dei pesticidi e dei fertilizzanti, aumento delle superfici coltivate a biologico e delle aree destinate alla biodiversità. Una transizione faticosa, che forse nessuno vuole davvero fare.
News