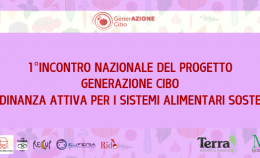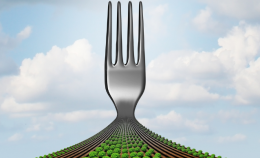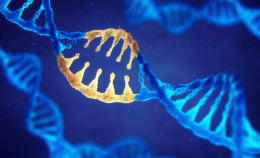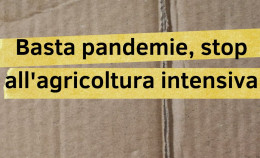Domande, risposte e proposte su guerra in Ucraina e prezzo del cibo
Pubblicato da Redazione
il 29/03/2022

Questo approfondimento è frutto di un lavoro collettivo svolto da ricercatrici, ricercatori e campaigner di Terra!, Greenpeace, Fairwatch e LIPU e mira a fornire risposte e proposte per evitare che la guerra in Ucraina venga strumentalizzata con l'obiettivo di indebolire o svuotare le politiche per la transizione ecologica dell'agricoltura
Nelle ultime settimane il conflitto in Ucraina ha acceso un grande dibattito sulla possibilità che il cibo scarseggi sulle nostre tavole e sulla necessità di intensificare la produzione di alcune materie prime sul nostro territorio, per evitare la dipendenza da paesi terzi le cui tensioni possono compromettere gli approvvigionamenti. Ucraina e Russia sono infatti grandi esportatori di cereali e oli vegetali, il che avrà conseguenze negative sulle forniture globali. I due paesi coprono il 30% del commercio globale di grano tenero, il 32% di orzo, il 17% di mais e oltre il 50% di olio di girasole, semi e farine di semi di girasole. Diversi paesi in Medio Oriente e Nord Africa importano oltre il 50% del loro fabbisogno di cereali e gran parte di grano e orzo dall'Ucraina e dalla Russia. L'Ucraina è poi un importante fornitore di mais per l'Unione Europea e la Cina, così come per diversi mercati nordafricani tra cui Egitto e Libia.
Tuttavia, questi numeri vanno messi in prospettiva e nel loro contesto, perché sono il frutto di fattori diversi, strutturali e precedenti il conflitto in atto, mentre vengono utilizzati anche in maniera strumentale dalle lobby agroindustriali, influenzando la politica e preoccupando i consumatori con una retorica che vorrebbe la guerra in Ucraina come potenziale causa di una carestia in Europa e principale responsabile dell’aumento dei prezzi del cibo.
Non è così e di seguito alcune domande chiave chiariscono perché.
Domande e risposte
1) Mancherà il cibo in Italia?
Per l’Italia la crisi in atto è principalmente una crisi del settore zootecnico, che una crisi del cibo.
Si parla di disponibilità e prezzi dei cereali, ma è bene chiarire come questi vengono utilizzati a livello europeo: il 53% dei cereali prodotti e importati in Ue sono destinati ad alimentare gli animali negli allevamenti europei, per la maggior parte intensivi, mentre solo il 19% è destinato al consumo umano. Oltre il 70% dei terreni agricoli europei è destinato all’alimentazione animale. In Italia il 58% dei seminativi è destinato ad alimentare animali, non persone.
Nel 2020 quasi metà del grano (duro e tenero) utilizzato in Europa è servito ad alimentare gli animali allevati: 49 milioni di tonnellate destinate al “feed”, a fronte dei 55 milioni per il “food”. Nonostante questo, le scorte di grano globali, nelle proiezioni fatte da AMIS per l’intero anno 2022, sono previste leggermente al di sopra dei livelli di apertura, soprattutto nell'UE. In totale si stima che a fine 2022 le scorte globali saranno pari a 291 milioni di tonnellate.
Al di fuori della filiera mangimistica, e quindi zootecnica, un’effettiva carenza è già in atto per quanto riguarda l’olio di girasole, usato nell’industria alimentare dei prodotti lavorati e nella ristorazione, e di cui l’Ucraina copre un terzo del nostro consumo nazionale.
Segue un focus per ognuna delle materie prime principalmente interessate.
La Russia è all’undicesimo posto dei paesi esportatori di questa materia prima (che utilizziamo per fare la pasta), mentre l’Ucraina è venticinquesima. A dominare la classifica è di gran lunga il Canada, che con 5,6 milioni di tonnellate nel 2020 supera di cinque volte la Francia, seconda esportatrice (1,1 milioni di tonnellate). La guerra ha quindi un limitato impatto sulle forniture di questo cereale per l’Ue. L’Italia dal canto suo è il principale produttore europeo e il secondo al mondo (dopo il Canada) per produzione di grano duro. Il nostro fabbisogno di grano è coperto dalla produzione interna per circa il 56% (ISMEA – 2020) e per la quota restante (2,2 milioni di tonnellate nel 2021 – ISMEA) importiamo prevalentemente proprio dal Canada (1 milione di tonnellate). Un rischio per le forniture esiste, ma è legato al calo di produzione dovuto al cambiamento climatico, e in particolare alla siccità che ha colpito il Canada nell’ultimo anno, abbattendo la sua produzione di grano duro del 60%, una siccità che sta mettendo a rischio anche i prossimi raccolti in Italia. Chi sostiene che la guerra potrebbe causare una carenza di pasta sugli scaffali dei supermercati, sta dicendo qualcosa non sostanziato dai fatti.
Appena un 35% di questa materia prima, utilizzata per pane e farine, viene dal nostro paese, che nel 2022 ne produrrà – secondo le stime – circa 2,8 milioni di tonnellate (ISMEA, 2020) a fronte delle 7,5 consumate nel 2020. Tuttavia le importazioni italiane dipendono solo per il 3% dal grano tenero prodotto in Ucraina. L’importazione totale, infatti, vale circa 4,5 milioni di tonnellate, reperite in gran parte sul mercato europeo, con prevalenza di acquisti da Ungheria e Francia. Diversi paesi in Medio Oriente e Nord Africa, al contrario, dipendono da Russia e Ucraina per quote significative del loro import. Kiev e Mosca coprono il 31% dell’export globale di grano tenero e hanno forti partner in paesi come Libano, Egitto, Tunisia, Yemen ed Etiopia, i quali prendono da Russia e Ucraina dal 40 al 95% delle loro importazioni. Per questi paesi, dunque, la guerra e l’aumento dei prezzi rappresenta un importante fattore destabilizzante.
La vera esposizione dell’Italia con l’Ucraina è sull’olio di girasole, impiegato nella produzione di conserve, salse, maionese e altri prodotti destinati alla grande distribuzione. Inoltre, i ristoranti lo utilizzano in grandi quantità per le fritture. Più di un terzo del nostro consumo annuo (770 mila tonnellate nel 2021 secondo ASSITOL) è coperto dalla produzione del paese est europeo. Da noi se ne producono 250 mila tonnellate, quello che rimane viene da fuori, il 63% proprio da Kiev (circa 330 mila tonnellate). L’Ucraina esporta il 44% dell’olio di girasole del mondo e detiene il primo posto come paese produttore, mentre la Russia è il secondo esportatore con il 20%. Il 12 marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una misura temporanea che apre all’utilizzo di olio di palma e altri oli vegetali in sostituzione del girasole, a fronte di una indicazione in etichetta. Rischiamo quindi di sopperire ad una carenza di materia prima con una ancora più impattante sugli ecosistemi e responsabile di una deforestazione selvaggia in Indonesia e Malesia.
Solo il 12% del mais a livello globale è effettivamente consumato per il cibo, mentre il 60% è usato come mangime per gli animali. Anche in Italia la maggior parte del mais disponibile è destinata all’uso zootecnico (82%), mentre solamente una percentuale minore è utilizzata per altri impieghi (18%). Le importazioni di mais dell’Italia rappresentano poco meno del 50% della domanda interna, in aumento da alcuni anni in conseguenza del crollo delle superfici a mais in Italia dovuto a fattori climatici e di mercato. Dall’Ucraina proviene quasi la metà del mais importato in Europa e questo Paese rappresenta per l’Italia il secondo fornitore dopo l’Ungheria, coprendo il 13% delle nostre importazioni. Questi numeri sono fonte di grande preoccupazione per la zootecnia italiana, data la ormai strutturale dipendenza degli allevamenti dal prodotto di provenienza estera.
Sia i fertilizzanti azotati, come l’ammoniaca e l’urea, che quelli di potassio sono colpiti da questo conflitto: la Russia rappresenta il 15% del commercio globale di fertilizzanti azotati e il 17% delle esportazioni globali di fertilizzanti potassici. L’Italia, tuttavia, spiega ISMEA, “è un mercato di destinazione della Russia poco rilevante”, Solo il 7% delle nostre importazioni nel 2021 è venuto da Mosca, il 6% da Kiev. L’italia acquista infatti soprattutto dall’Egitto, che copre il 50% delle forniture. Secondo i Consorzi agrari d’Italia, nell’ultimo anno il prezzo dei fertilizzanti è schizzato del 2-300% passando in alcuni casi da 350 ad oltre 1000 euro a tonnellata. Disponibilità e costi sono però legati anche al prezzo del gas, materia prima fondamentale per il processo produttivo e il trasporto di fertilizzanti, come dettagliamo in seguito.
2) Prezzi alle stelle, da quando e perché?
È importante notare che i prezzi dei prodotti alimentari sono già in aumento da tempo a causa di diversi fattori, tra cui la pandemia di COVID, le interruzioni delle catene di approvvigionamento, l'aumento dei prezzi dell'energia e gli eventi meteorologici estremi, ai quali si aggiungono fenomeni speculativi.
L'indice dei prezzi alimentari della FAO di febbraio 2022 era del 20,7% più alto rispetto al febbraio 2021. I modelli climatici prevedono ulteriori impatti negativi sulla crescita dei raccolti, e quando i raccolti sono inferiori al previsto, i prezzi di queste materie prime aumentano. La volatilità dei prezzi agricoli e le innumerevoli crisi degli ultimi anni, inoltre, hanno indotto spesso i produttori a non seminare, per non sostenere costi certi - semi, pesticidi, fertilizzanti - a fronte di guadagni incerti. In un Paese come quello italiano in cui la maggior parte dei produttori agricoli è di piccola taglia e l’unione consortile fa la forza, la scelta è spesso last minute, e danneggia la disponibilità interna in modo imprevedibile.
Alla disponibilità diretta delle materie si aggiungono inoltre fattori indiretti: l’aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, così come quello dei fertilizzanti, sono tutti fattori non direttamente legati ai volumi prodotti, e quindi non direttamente risolvibili con l’aumento di produzione. Già a ottobre scorso, infatti, le riviste di settore avvertivano che per i produttori italiani le riduzioni di margine rispetto al 2021 (nonostante i prezzi di vendita in costante rialzo) nel 2022 sarebbero ammontate a poco meno di 300€ a ettaro per il grano tenero e 250€ per ettaro per il grano duro. Per il grano tenero, computando anche gli affitti, i rincari a parità di resa avrebbero portato il margine, anche con condizioni generali pre-belliche, non a guadagnare, ma a perdere tra i 250€ e 100€ per ettaro.
+74%: è l’aumento della quotazione di borsa del grano rispetto allo scorso anno, +20% è quello della soia, +37% quello del mais secondo gli indici del Wall Street Journal - che stabilizzano una media delle principali borse dedicate - nella prima settimana del conflitto in corso. Significa che le attività finanziarie legate alle principali materie alimentari ribollono. Acquistare, ad esempio, futures (i principali strumenti finanziari di settore) sul grano o su altre materie prime alimentari, significa impegnarsi ad acquistare a una scadenza prestabilita un raccolto a un certo prezzo negoziato che, in teoria, dovrebbe contenere i prezzi di riferimento dei principali costi di produzione. Dovrebbe, dunque, funzionare per garantire risorse “fresche” all’agricoltore (perché l’acquisto del “titolo” avviene in anticipo rispetto alla effettiva produzione), proteggendolo dalle fluttuazioni dei prezzi. Chi acquista il future può poi rivenderlo a un prezzo maggiorato. In realtà, però, da quando (come ha appofondito anche l'Associazione Rurale Italiana) banche d’affari e fondi di investimento sono tra i protagonisti della compravendita di questi strumenti, la maggior parte dei futures vengono rivenduti o terminati prima della scadenza, nei momenti di picco di quotazione, a prescindere dall’effettivo andamento e disponibilità dei raccolti. Nei momenti come quello che stiamo vivendo, in cui si moltiplicano previsioni sugli andamenti futuri a prescindere da quanta materia prima sia effettivamente disponibile, si moltiplicano gli scambi che ‘scommettono’ sui prezzi futuri delle materie prime, di fatto trascinandoli alle stelle. Senza dimenticare il peso degli scambi over the counter: operazioni di compravendita di titoli che non figurano nei listini di borsa, la cui funzionalità è organizzata da alcuni attori, (es. Bloomberg) e le caratteristiche dei cui contratti negoziati non sono standardizzate. È un fatto che, nella prima settimana di conflitto, la compravendita dei futures sul grano solo nel mercato ufficiale sia cresciuta tra il 40 e il 60%, e il prezzo della farina macinata alla borsa di Parigi sia schizzato al livello record di 400 euro la tonnellata.
L’aumento dei prezzi del grano duro ha solo parzialmente a che fare con il conflitto in Ucraina. È figlio invece del crollo della produzione canadese, che ha segnato un -60% nel 2021 rispetto al 2020. La causa? Una siccità prolungata che ha fatto collassare i raccolti, riducendo le scorte globali, fatto che dimostra come i fenomeni climatici estremi sempre più intensi possano avere un impatto deflagrante su filiere alimentari globalizzate. Il problema, infatti, è che il nostro paese dipende fortemente dalle importazioni di grano duro, perché produce solo il 60% di quello che utilizza. Da notare però che il nostro paese importa ogni anno circa 2,2 milioni di tonnellate di grano duro ed esporta 2,3 milioni di tonnellate di pasta (ISMEA, 2021). Se il settore non fosse così legato alle esportazioni, dunque, sarebbe anche meno esposto alla volatilità dei prezzi. Invece oggi 1 kg di pasta costa il 14% in più di un anno fa e il 22% rispetto a 3 anni fa.
Il boom dei prezzi di pane e farine ha messo in allarme l’industria molitoria e il settore della panificazione in Italia. Si registrano infatti crescite che a gennaio, secondo l’ultimo dato raccolto dall’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico, vedono il pane arrivare a una media di 5.30 euro al kg. Tuttavia, l’aumento dei prezzi è iniziato nel 2020, come dimostrano i comunicati degli industriali di Italmopa. Non è dunque possibile imputare tutte le responsabilità al conflitto in Ucraina: è invece necessario concentrarsi sul ruolo della speculazione finanziaria sulle quotazioni della materia prima. Il grano tenero (come il mais e altre commodities) è infatti quotato in borsa e oggetto di contratti a termine (i cosiddetti futures), il cui valore è soggetto saliscendi speculativi, che impattano sull’economia reale indipendentemente dalla concreta carenza di materia prima.
L'Ucraina fornisce quasi la metà del mais dell'UE e copre circa il 15% delle importazioni italiane di questo prodotto. Dallo scorso 24 febbraio, alla Borsa merci di Chicago, la quotazione del mais in consegna a marzo ha mostrato oscillazioni giornaliere molto marcate ma con tendenza rialzista. In Italia il prezzo rilevato dall’ISMEA ha raggiunto 283,10 euro a tonnellata lo scorso febbraio (+27% su febbraio 2021), valore mai toccato prima nella serie storica di rilevazioni fatte dall'istituto. La guerra in Ucraina ha quindi un impatto diretto sulle filiere zootecniche, principale destinazione di questo cereale. L’aumento dei prezzi non è però esclusivamente collegato al conflitto, ed è infatti in atto da tempo, a causa di fattori indiretti, come l’aumento del costo dell'energia e dei fertilizzanti, o l’effetto sui mercati della risalita della domanda cinese, dopo lo stop imposto dalla peste suina del 2019.
Il settore dei fertilizzanti ha subìto un rialzo spettacolare negli ultimi mesi, seguendo un trend cominciato però già nel 2021, che oggi - come dimostrano i calcoli della Banca Mondiale, ha portato il prezzo vicino ai livelli del 2008. Gli aumenti anno su anno toccano percentuali del 2-300% (a seconda del prodotto), ma sebbene la guerra abbia un impatto innegabile su questa dinamica le cause più importanti vanno ricercate altrove. Ad esempio nel picco dei prezzi del gas, materia prima fondamentale per il processo produttivo e il trasporto di fertilizzanti. Ammoniaca e urea, composti base di questi nutrienti, vengono infatti prodotti a partire da metano e azoto utilizzando il processo di Haber-Bosch. Più costa il gas, più salgono i prezzi dei prodotti. Una ragione in più per superare al più presto un’agricoltura fossile e dipendente da input esterni, piuttosto che limitarsi alla diversificazione delle forniture. In questo percorso, le strategie europee Farm to Fork e Biodiversità sono un aiuto, non un ostacolo.
3) Le pericolose richieste delle lobby agricole
Le lobby agricole stanno utilizzando la crisi per reiterare le richieste di sempre: abbassare gli standard ambientali e intensificare le produzioni. Se il governo darà loro ascolto, l’agricoltura italiana ed europea rischia di essere sempre più esposta ai cambiamenti climatici e alle crisi globali.
In nome dell’aumento della produzione i gruppi di interesse hanno ottenuto di derogare da una delle condizioni per accedere agli incentivi PAC dell’attuale programmazione. Per l’anno 2022, infatti, la Commissione Europea ha appena esentato gli agricoltori dall’obbligo del rispetto del cosiddetto “greening”, che ora prevede il mantenimento di spazi non produttivi dedicati alla biodiversità o la coltivazione di colture azotofissatrici (con un uso di pesticidi limitato nel tempo).
Ma non basta: le lobby e alcuni Stati membri chiedono di eliminare (o di indebolire fortemente) le regole anche per la programmazione 2023-2027 che prevedono il mantenimento di una percentuale minima del 4% di aree naturali, applicata per altro ai soli seminativi. Questo è frutto dell’attacco a uno degli obiettivi della strategia europea Biodiversità, che punta a utilizzare il 10% delle superfici agricole per aree ad alta biodiversità. È evidente come sia strumentale spostare la discussione su strategie che proiettano i loro effetti e obiettivi su scadenze di medio e lungo periodo, mentre per molte aziende agricole la sopravvivenza è questione di giorni o settimane: la nuova PAC infatti entrerà in vigore dal 2023 e sarà pienamente operativa dal 2025 e la strategia Biodiversità pone obiettivi da raggiungere entro il 2030. Anche se queste richieste saranno accolte, non vi sarà alcun beneficio per le aziende nell’immediato, mentre lo stato della biodiversità delle aree agricole, già pesantemente compromesso, sarà sempre più a rischio, a danno anche della resilienza della nostra agricoltura.
Per il duro, dagli 1,4 milioni di ettari del 2016 nel 2020 siamo scesi a 1,21 milioni di ettari. Senza miglioramenti della capacità degli agricoltori di ottenere giuste remunerazioni, non sarà l’aumento delle superfici a risolvere il problema.
Il contenuto del recente rapporto dell’ISPRA (2021) intitolato “Transizione ecologica aperta. Dove va l’ambiente italiano?” indica infatti nell’agricoltura la principale causa delle pressioni che hanno agito su specie e habitat terrestri e sulle acque interne di interesse comunitario nel periodo 2013–2018. A dimostrazione di ciò si evidenzia come il Farmland Bird Index Italiano* al 2020 presenti un calo del 30% (dal 2000), dato simile a quello registrato per l’indice delle specie legate alle praterie montane (-28.8%). Oltre a non essere utile nell’immediato, non è necessario aumentare le superfici potenziali, perché assistiamo da anni a una progressiva riduzione delle superfici nazionali coltivate: la superficie impiegata per il frumento tenero subisce un costante calo dal 2012 del 6% su base annua e si attesta nel 2020 a poco meno di 501 mila ettari. Per il duro, dagli 1,4 milioni di ettari del 2016 nel 2020 eravamo a 1,21 milioni di ettari. Senza miglioramenti della capacità degli agricoltori di ottenere giuste remunerazioni, non sarà la crescita delle aree coltivabili a risolvere il problema.
Nella loro spinta all’intensificazione delle produzioni, i gruppi di pressione chiedono di rimandare anche un altro obiettivo: quello di ridurre del 50% l'uso dei pesticidi più pericolosi e di ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi chimici in genere, presente sia nella Strategia europea biodiversità 2030 che nella Farm to Fork (“costola” agricola del Green deal europeo). Anche in questo caso, oltre a non avere un effetto nell’immediato - essendo un obiettivo fissato al 2030 - si rischia di rendere nel medio e lungo periodo la nostra agricoltura ancora più dipendente da input esterni, e di conseguenza esposta alla volatilità dei prezzi e degli scambi commerciali. Senza citare i noti impatti che i pesticidi hanno sull’inquinamento del terreno e delle acque, anche a distanza di anni dal loro utilizzo, con conseguenze dirette anche sulla salute umana. Il rischio è di ipotecare ulteriormente il futuro dei nostri suoli agricoli, senza che questo abbia alcun effetto positivo nell’immediato nel contrasto all’attuale crisi.
La domanda, in particolare delle associazioni zootecniche, è di aprire alle importazioni di mais che non soddisfano la legislazione comunitaria o i disciplinari italiani per quanto riguarda OGM e residui di pesticidi. Insieme a questa richiesta si affaccia anche l’apertura alle cosiddette NBT (New Breeding Techniques), riconosciute da una sentenza della Corte di Giustizia UE come OGM a tutti gli effetti - e sottoposte quindi alle stesse regole per valutazione del rischio, tracciabilità ed etichettatura - che le multinazionali del genome editing cercano da tempo di sdoganare e immettere sul mercato. Assecondare queste richieste significa derogare dal principio di precauzione e abbassare gli standard alimentari e sanitari delle nostre produzioni, mettendo a rischio ambiente e salute - oltre che il tanto rinomato Made in Italy - invece di mettere in discussione la sovrapproduzione di carne e derivati e relative risorse necessarie, così come un modello agroindustriale insostenibile per salute, ambiente e clima.
Appare evidente come la crisi in atto sia più una crisi dei mangimi che una crisi del cibo, motivo per cui le associazioni di categoria stanno chiedendo ulteriori fondi pubblici e deroghe sui limiti dei pagamenti accoppiati, cioè fondi supplementari assegnati tramite la politica agricola comune a quelle produzioni considerate strategiche dai vari paesi membri.
Il settore zootecnico italiano è però un sistema che già da anni si sostiene grazie a ingenti iniezioni di fondi pubblici, poiché le “crisi” che lo affliggono sono ormai strutturali. Gli allevatori sono spinti a produrre sempre di più con margini di guadagno sempre più bassi, i costi delle materie prima sono in continuo aumento, anche a causa dei cambiamenti climatici che impattano sulla disponibilità di colture destinate alla mangimistica, così come i costi dell’energia e dei carburanti. A questo si è aggiunta la pandemia da Covid, che ha frenato un mercato che ciclicamente già vedeva momenti di crisi, e le continue epidemie legate ai virus che proliferano negli allevamenti intensivi, come dimostra l’ultima ondata di aviaria in Italia. Tutti questi fattori indicano che il sistema degli allevamenti intensivi è vittima e al contempo causa dei mali che lo affliggono, e che solo con un cambiamento radicale, accompagnando i produttori in un vero percorso di transizione e una drastica riduzione delle quantità, potrà raggiungere una sostenibilità economica e ambientale.
Il picco dei prezzi del gas sta spingendo lobby agricole e Confindustria a chiedere un’accelerazione - già prevista nel PNRR - del biometano agricolo, che andrebbe prodotto anche a partire dagli scarti e dalle deiezioni degli animali allevati. È bene chiarire che la necessaria transizione dai combustibili fossili deve passare da un forte incremento delle energie rinnovabili, ma non può essere raggiunta solo passando dal gas e dal petrolio russo ai biocarburanti o al biogas. Una spinta senza regole chiare per evitare che l’uso dei terreni entri in competizione con la produzione di alimenti o mangimi aggraverebbe ulteriormente lo scenario attuale di prezzi e disponibilità di materie prime, oltre che la biodiversità. La vera transizione energetica deve essere basata sulla riduzione del consumo di energia e sulle rinnovabili pulite, per esempio attraverso ristrutturazioni, isolamento degli edifici, pompe di calore ed energia eolica e solare.
Essendo gli impianti a biogas alimentati non solo da scarti o reflui zootecnici, ma anche da piantagioni dedicate (in Italia parliamo oggi di 150-200 mila ettari di quel mais di cui si paventa la scarsità), rischiano infatti di diventare la scusa per non intervenire su un comparto - quello dell’allevamento intensivo - che necessiterebbe invece di una importante transizione e una riduzione del numero di animali allevati, e di entrare direttamente in competizione con la domanda di materie prime agricole da parte del comparto alimentare.
4) Le nostre proposte
L’Italia e l’Europa non hanno bisogno di produrre di più, ma di produrre e consumare in modo diverso, come afferma anche il recente appello di 180 scienziati internazionali, secondo cui la crisi attuale è legata più a una iniqua distribuzione delle risorse che non a un problema di approvvigionamenti. Abbiamo cibo a sufficienza per sfamare il mondo anche ora, durante questa guerra.
È necessario però dare priorità alla produzione di cibo per le persone piuttosto che a quella di mangimi per animali rinchiusi negli allevamenti intensivi.
È urgente accelerare la transizione verso un sistema agroalimentare più resiliente e meno dipendente da input esterni come pesticidi e fertilizzanti di sintesi, basato su sistemi agroalimentari locali e di piccola scala.
È inoltre cruciale mettere in discussione l’uso di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti, quando potrebbero essere utilizzate come cibo.
La trasformazione del sistema è l’unica via per assicurare la sostenibilità a lungo termine: un fallimento danneggerà infatti anche gli agricoltori, che sono le prime vittime dell’aumento e della volatilità dei prezzi delle materie prime, oltre ad essere in prima linea nel subire le conseguenze degli eventi legati al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità.
* Il Farmland Bird Index è un indicatore ambientale che rappresenta lo stato di salute degli ambienti agricoli, aggregando le informazioni derivanti da singoli indici, quali le tendenze di popolazione delle specie di uccelli tipiche degli ambienti agricoli e degli ambienti aperti di montagna.
News